La società della prestazione: rendere sempre, non arrendersi mai
Ethic 01.07.2025 Mariana Toro Nader Tradotto da: Jpic-jp.orgIncantata dal dogma della prestazione, la società attuale sta iniziando a pagarne le conseguenze. Per alcuni si tratta di scegliere tra la crescita economica e il rispetto dei limiti individuali (e planetari): forse è possibile trovare una “giusta misura”.
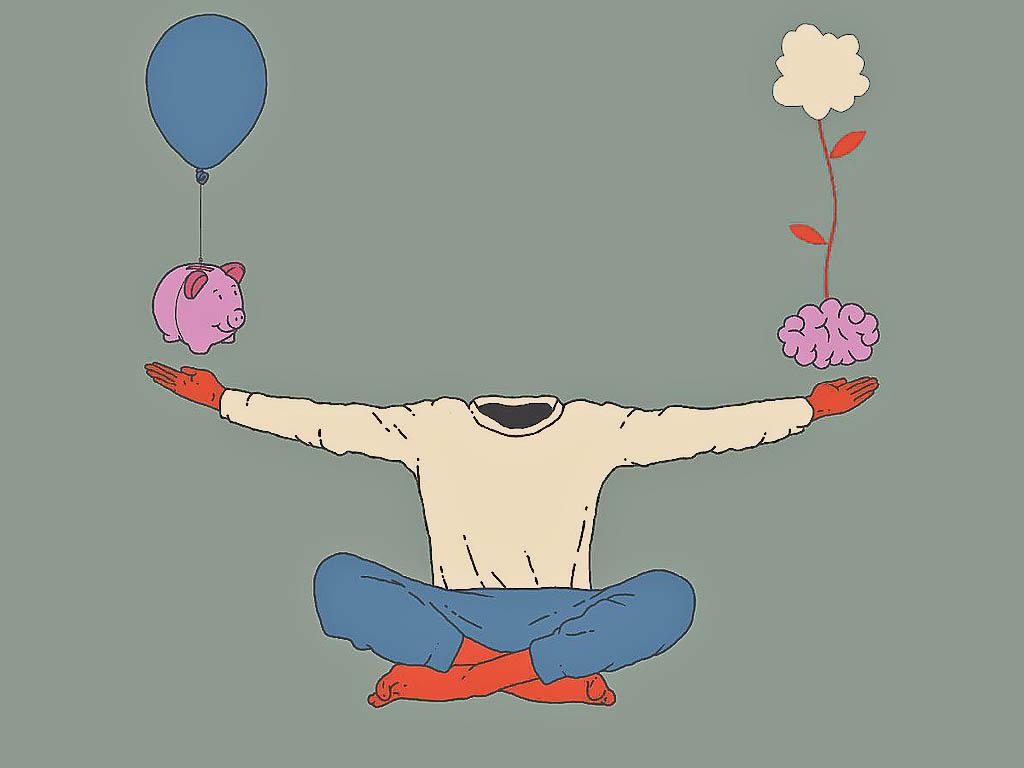
Lavorare più di 80 ore a settimana. Gratis. Questo fu l’appello lanciato da Elon Musk quando era a capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa degli Stati Uniti, rivolto ai “rivoluzionari dal quoziente intellettivo molto alto” per ottenere la riduzione dei costi. Lo stesso Musk ha dichiarato di lavorare, insieme ai suoi dipendenti, 120 ore settimanali. Considerando che una settimana ha 168 ore, ciò lascerebbe solo 6,8 ore al giorno (weekend inclusi) per dormire, mangiare, fare la spesa, andare a prendere i figli, stare con il partner, uscire con gli amici, fare esercizio fisico, lavare i panni, riordinare la casa, pagare le bollette e tornare in ufficio, visto che l’uomo più ricco del mondo ritiene che il telelavoro sia “una stronzata”.
Oltre l’aneddoto, ciò che preoccupa di più è che Musk non è l’unico magnate ad aver promosso tali misure per “scuotere il sistema”. Già alla fine del 2023, il miliardario australiano Tim Gurner sosteneva che il tasso di disoccupazione doveva aumentare del 40%-50% per “infliggere dolore all’economia” e “ricordare alle persone che lavorano per i loro datori di lavoro e non il contrario”. Queste dichiarazioni si inserivano nel contesto di un fenomeno iniziato dopo la pandemia di Covid-19 e proseguito negli anni successivi, noto come la Grande Dimissione, durante la quale milioni di lavoratori hanno lasciato in massa i loro impieghi, mettendo in discussione l’attuale modo di vivere e lavorare.
Un motore in fiamme
La nostra epoca ha ricevuto molti nomi: era digitale, era dell’attenzione, era della post-verità; società liquida, società dello spettacolo, società della stanchezza, del burnout. Ma, se si dovesse scegliere un solo termine, forse il più appropriato sarebbe “società della prestazione”. Oggi si parla di migliorare la prestazione economica, accademica, mentale, sportiva e perfino sessuale. Il mantra è fare tanto con poco. Fare tantissimo con il minimo. Ottimizzare. Far rendere il tempo, il cervello, le risorse. L’iperbole come norma.
Essere umani iper-iper — iper connessi, iper informati, iper produttivi e iper ottimizzati (o disperati di esserlo) — corrono senza tregua come “macchine di prestazione autistiche”, per usare le parole di Byung-Chul Han.
Per il filosofo coreano, la società contemporanea è passata da essere una società disciplinare (dove la pressione veniva dall’esterno) a una società della prestazione (dove la pressione proviene dall’interno). L’animal laborans non ha più bisogno del padrone col frustino: imprenditore di sé stesso, si auto-sfrutta.
L’homo agitatus, secondo Jorge Freire, è devoto all’agitazione e all’iperattività: deve “rendere sempre, non arrendersi mai”. Si spinge ai limiti — fisici e mentali — fino a fondersi per surriscaldamento. A forza di “mettersi le pile”, il meccanismo si inceppa. Da qui il nome burnout. Esausto, l’individuo di oggi soffre di un eccesso di potenza; non può permettersi di non farcela. Dai, ce la puoi fare, e se non ce la fai è perché non vuoi. Just do it.
Il non poter non farcela ha portato al fenomeno del bootstrapping: l’idea che ognuno sia (o debba essere) capace di migliorare sé stesso e le proprie condizioni solo con la disciplina, senza l’aiuto di nessuno. Si è così costruita una cultura del sovrasforzo che non solo ci spinge a superare costantemente i nostri limiti, ma che attribuisce la povertà alla mancanza di impegno personale.
Questo è stato il terreno fertile per la proliferazione dei cosiddetti productivity bros, descritti da Jenny Odell come “persone che fanno video per persone che si fanno video”, su rigide abitudini mattutine, consigli di gestione personale e formule magiche per ottimizzare il tempo. Influencer che si arricchiscono sostenendo “l’idea che una persona possa essere al tempo stesso chi si libera e chi si domina”. Esiste dunque una retorica di autocontrollo e di auto-sorveglianza che ci spinge a monitorare costantemente le nostre prestazioni, con fogli Excel, app piene di spunte, checklist di ottimizzazione o autovalutazioni. Perché ci sono sempre più successi da raggiungere, più minuti da ottimizzare, un corpo più snello da scolpire, e in generale più cose da possedere.
Ovviamente, per raggiungere i propri obiettivi è necessario uno sforzo. Tuttavia, il punto della hustle culture è che il divario tra ciò che si è e ciò che si potrebbe essere non si colmi mai. Che quella distanza rimanga incolmabile.
Ostentazione dell’agitazione
Insonnia, disturbi del sonno, nevrastenia, malattie croniche, problemi di salute mentale. Il mondo dorme sempre meno e peggio. L’84% dei lavoratori afferma di essere stressato dal proprio lavoro. L’ansia e la depressione si sono diffuse in tutte le fasce d’età, e in alcuni Paesi la percentuale di persone con malattie mentali raggiunge il 30%-40% della popolazione. Lo stress cronico attacca tutti i sistemi: aumenta la pressione arteriosa, indebolisce il sistema immunitario, accresce il rischio di ictus, compromette la capacità di attenzione e contribuisce all’invecchiamento precoce.
Anche se sappiamo che fa male alla salute, nella società della prestazione è strano non essere stressati. Lo stress si generalizza, si normalizza, anzi, viene quasi premiato socialmente. Da qui nasce la “sindrome della vita occupata”: ogni secondo è pieno di impegni e faccende. L’incapacità di affrontare i momenti vuoti dell’agenda — o il vuoto, in generale — trasforma la mancanza di tempo in un oggetto di ammirazione (e di vanto). La sociologa Michelle Shir-Wise la chiama “l’ostentazione dell’agitazione”. Guarda quanto sono occupato, guarda quanto sono capace. Lo stress come medaglia, il burnout come trofeo.
In inglese, performance society indica che il successo è direttamente legato al fare. E, come se l’auto-esigenza non bastasse, esperimenti come quelli della psicologa sociale Janice Kelly hanno dimostrato che i membri di una società si sottopongono reciprocamente a pressioni, generando una sorta di “effetto trascinamento”.
Tutto ciò, amplificato dalla vetrina 24/7 dei social media. Si performa e si produce per uno sguardo esterno. Il mondo esterno diventa teatro per creare contenuti per il mondo virtuale.
Secondo il sociologo della Columbia University David Stark, ciò che distingue questa società non è la prestazione in sé, ma il fatto che sempre più ambiti della vita vengono vissuti in termini di metriche di rendimento. Così, “mentre alcuni performano, altri tengono il punteggio”. Allenatori e statistici misurano le prestazioni degli atleti. Le aziende monitorano la performance dei dipendenti, le borse valutano il rendimento delle imprese, e gli indicatori ci dicono quali nazioni sono più o meno libere, democratiche o corrotte.
Perfino il tempo “libero” è stato invaso da faccende e classifiche: le vacanze a casa non sembrano più vere vacanze; bisogna viaggiare di più, leggere più libri, guardare più serie e film, visitare più luoghi, caricare più stories, vivere di più e meglio (e soprattutto mostrarlo). Si parla allora di “economia dell’esperienza”, un nuovo consumo ostentativo che non riguarda più solo i beni acquistati, ma anche le esperienze vissute: spiagge da sogno, ristoranti alla moda, glamping di lusso… all’infinito.
Il marketing ha studiato a fondo l’uso (pare inesauribile) dell’“invidia da social network”. Uno studio del 2017 ha mostrato che due millennials statunitensi su cinque sceglievano le proprie mete di viaggio in base al loro potenziale “instagrammabile”. L’ironia è che queste dinamiche hanno invaso anche attività che puntavano al contrario: cura di sé, silenzio, disconnessione sono divenuti prodotti di lusso. Perfino la lettura si è trasformata in uno spazio performativo, dove attraverso post sui social o sfide su Goodreads si esibisce chi legge più libri, chi è più aggiornato sulle ultime uscite… Classifiche e punteggi. Top 5, top 10. Competizione e confronto.
Rallentare
“Gli uomini attivi rotolano, come rotola una pietra, secondo la stupidità della meccanica”, scriveva Nietzsche. Quando l’iperattività è la norma, il tempo libero e le pause diventano solo parentesi per recuperare e tornare a lavorare. Ma, come afferma Freire, il contrappeso all’agitazione non è il riposo, bensì l’apatia: si esagera il movimento per nascondere l’impotenza.
Per la filosofa María Novo, stiamo fuggendo “dalla nostra condizione di esseri con limiti: la grandezza, la lontananza e la velocità sono tentativi di superare le barriere della natura e della nostra natura”. Una fuga collettiva in avanti.
Lo storico Lewis Mumford ricordava che non fu la macchina a vapore ma l’orologio la vera macchina dell’era industriale. Ora, gli orologi sono ovunque, perfino a contare i battiti del cuore. Timer e cronometri sono i meccanismi per eccellenza della misurazione della prestazione.
Stiamo vivendo quella che lo scrittore Robert Colville chiama la Grande Accelerazione. Ma questa va oltre il progresso tecnologico e le pressioni del lavoro: la comunità scientifica avverte da anni degli effetti ambientali devastanti dell’attuale modello di produzione e consumo. E, secondo Odell, questo ha portato a una “nausea spirituale e nichilista” di fronte “all’idea di correre contro il tempo verso la fine del mondo”.
Di fronte alla crisi climatica imminente, scienziati, economisti, politici e pensatori si interrogano su quale strada prendere per costruire un modello che rispetti davvero i limiti planetari (e individuali). Alcuni propongono la decrescita economica; altri, come il Rapporto Draghi, mettono in guardia sulle conseguenze della riduzione del PIL sullo stato sociale. Ma e se non fosse una questione di somma zero?
Per l’economista Toni Roldán, “le società più produttive non hanno problemi di ansia maggiori: in Danimarca lavorano meno ore e hanno un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata. Dobbiamo essere più produttivi per vivere meglio”. Il filosofo Carlos Javier González Serrano sostiene che la disgiuntiva tra iperproduttività e stato sociale sia falsa e interessata. La chiave, secondo lui, sta nel costruire un’economia che non divori i soggetti che la sostengono.
Alla fine, nessuna azienda ha interesse ad avere lavoratori bruciati, e nemmeno i governi. Secondo un rapporto Gallup, “il disimpegno dei dipendenti costa all’economia mondiale 8.900 miliardi di dollari, pari al 9% del PIL globale”. González lancia una domanda: “Perché ci parlano dello stato sociale solo in termini economici? E se il benessere avesse più a che fare con la costruzione di una società più frugale, che non debba stimolare costantemente il desiderio dei consumatori?”
Perché, sebbene il potere d’acquisto sia importante, il benessere e lo sviluppo vanno ben oltre. Come ammoniva il Nobel Amartya Sen, non ha senso considerare la crescita economica come fine a sé stessa: lo sviluppo deve migliorare la vita che conduciamo. Inoltre, come osserva lo psichiatra Carlos Cenalmor, “una persona sana e felice è sempre più produttiva di una che non lo è”. Il World Happiness Report delle Nazioni Unite e l’indagine sulle condizioni di lavoro europee lo dimostrano: uno dei fattori che più incidono sulla qualità della vita è il tempo dedicato alle relazioni umane — famiglia, amici, comunità.
Aurea Mediocritas
Da qui, nascono proposte di politiche pubbliche per garantire il “diritto al tempo”. L’adozione della settimana lavorativa di quattro giorni in Paesi come Germania, Islanda e Portogallo ha dimostrato che la conciliazione tra lavoro e vita privata non sacrifica la produttività delle imprese. Anzi.
Forse è proprio lì che risiede la “giusta misura” aristotelica: capire che rallentare non significa fermarsi. Negli ultimi tempi, la lentezza sta emergendo come via per riconnettersi con l’ambiente e i ritmi naturali. Per vivere con l’attenzione meno dispersa, con uno sguardo meno frenetico.
Lo scrittore Oliver Burkeman lo esprime in modo semplice: forse non tutte le attività sono essenziali per la sopravvivenza; forse non è un obbligo universale guadagnare sempre di più, raggiungere sempre più obiettivi o realizzare il proprio potenziale in tutte le sfere. Così, Jenny Odell consiglia di sperimentare, in qualche ambito della vita, ciò che potrebbe sembrare mediocrità. E chiedersi: a chi sembra mediocre, e perché?
Perché il burnout non riguarda solo la mancanza di tempo: è legato al senso della vita. Forse la domanda più importante è cosa significhi davvero “vivere la propria vita migliore”. Anche perché, con ogni probabilità, non esiste un’unica risposta, né per tutti, né in tutte le fasi della vita.
La fretta e l’immediatezza appiattiscono il contesto e cancellano le sfumature. Andare più lentamente crea spazio per interrogarsi, recuperare l’intenzionalità e uscire dall’intorpidimento. Perché una cosa è il movimento, un’altra è l’inerzia. Il movimento richiede intenzione, pause, significato. È possibile continuare a muoversi, correggendo di tanto in tanto la rotta. Forse si tratta solo di modulare il ritmo.
Ver, La sociedad del rendimiento: ¿rendir o rendirse?
Ilustración: Óscar Gutiérrez





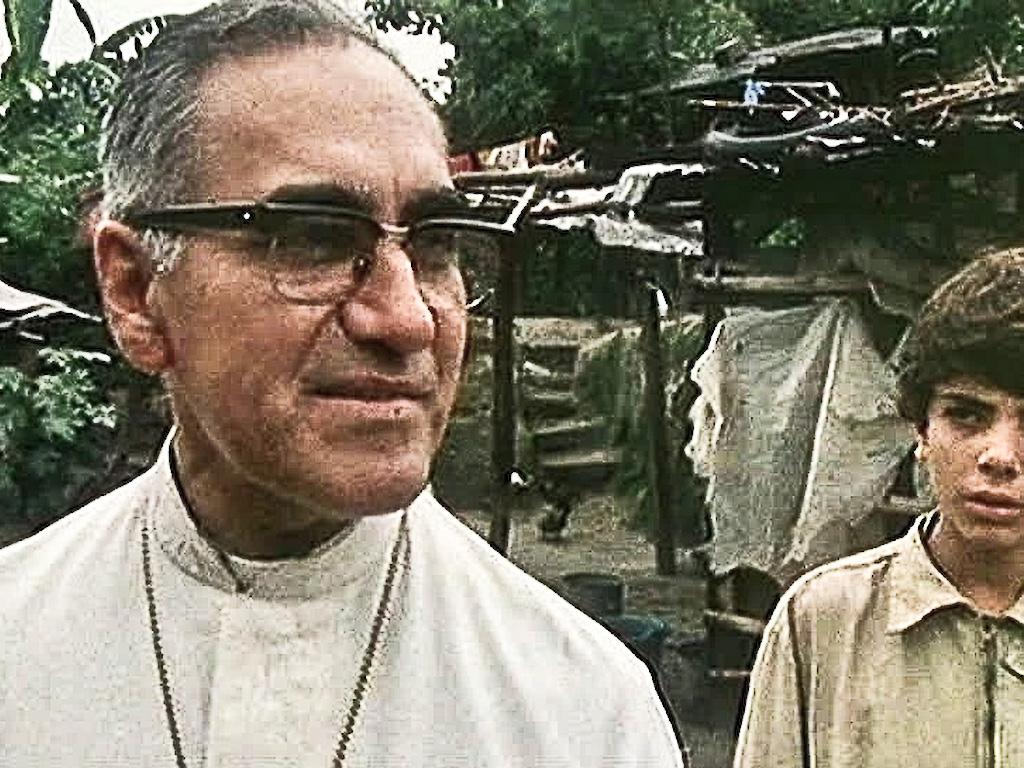

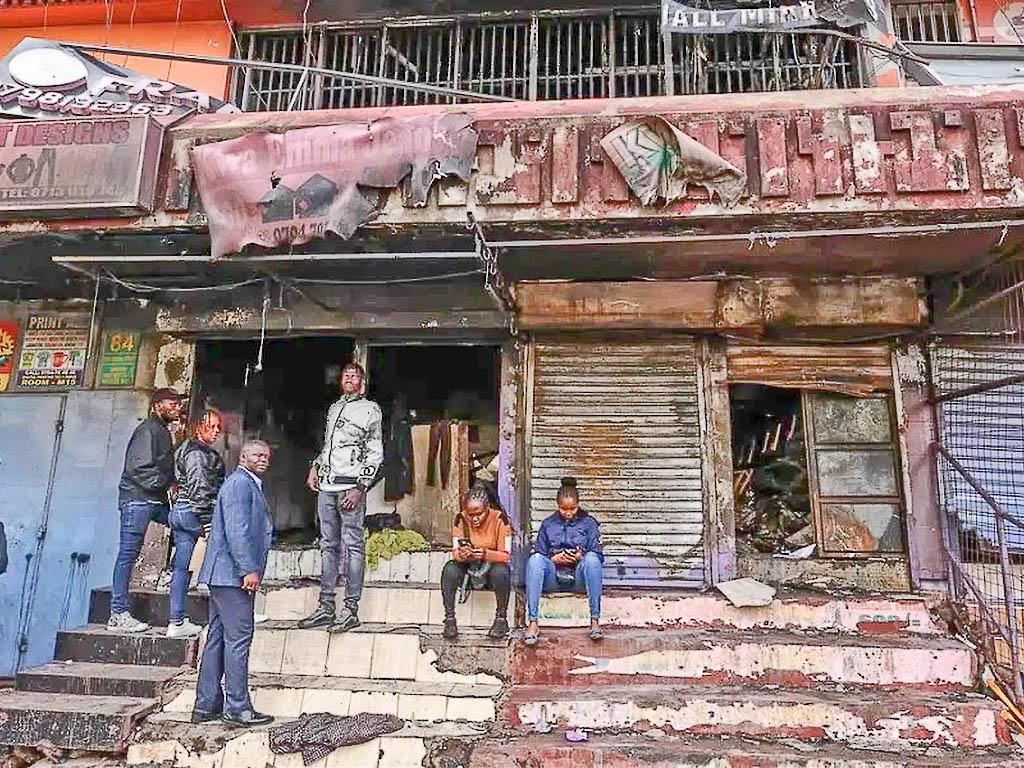

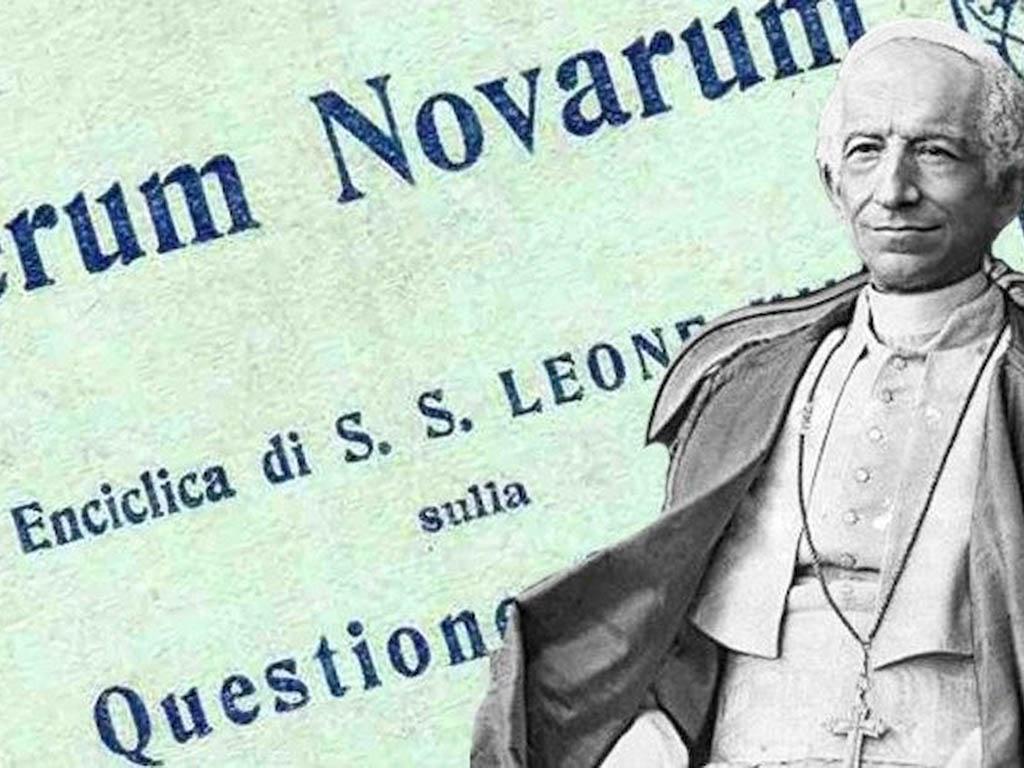



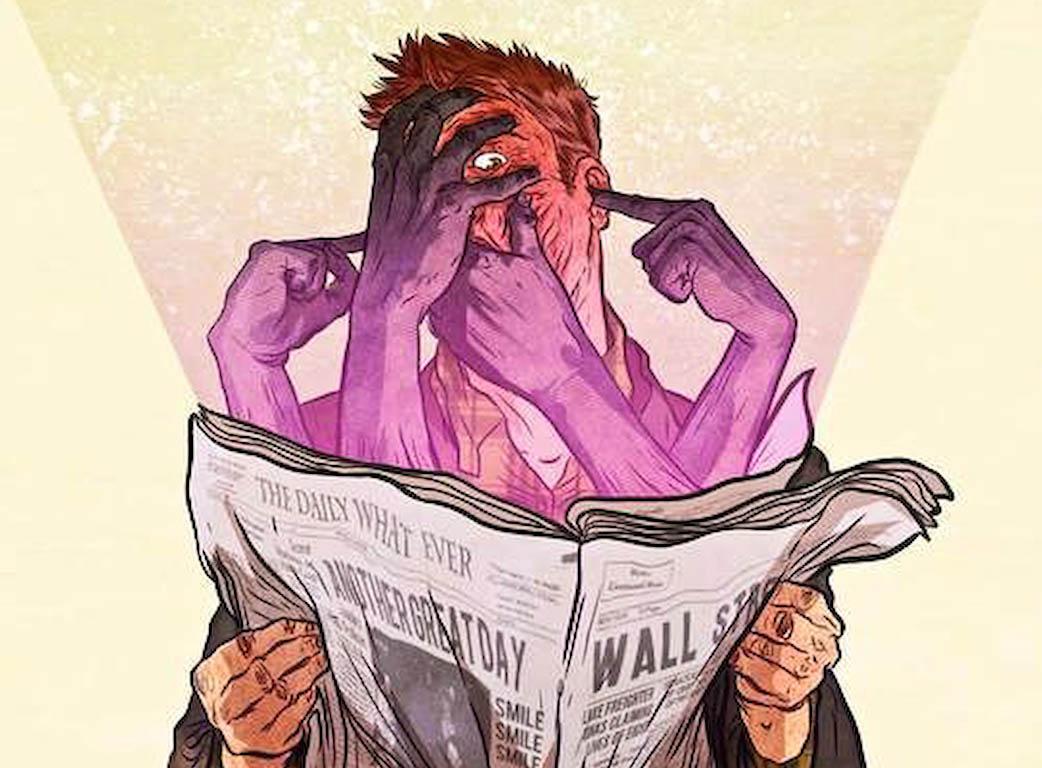







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento