Senza legami morali non esiste il senso del bene comune
Ethic 27.10.2025 Pedro Silverio Tradotto da: Jpic-jp.orgVictoria Camps (Tarragona, 1941) è una delle grandi filosofe spagnole contemporanee. Punto di riferimento nel campo dell’etica, ha appena pubblicato ‘La società della sfiducia’ (Arpa, 2025), in cui analizza i principali errori che stiamo commettendo come società e ci invita, sempre in una prospettiva critica, a ripensare le cause del nostro smarrimento e le vie per rimediare. Per lei, una cosa è certa: il concetto di libertà è stato corrotto dal suo sviluppo eccessivo, e abbiamo dimenticato di cooperare come individui che convivono in una società.
Intervista.

Nel suo precedente libro, Il tempo della cura, lei affrontava la necessità di prenderci cura della società. Questo nuovo libro sembra fare un passo oltre: se non siamo capaci di prenderci cura, cerchiamo almeno di recuperare la fiducia. Lei afferma che servono cambiamenti urgenti. Parla di rivoluzioni, di una riforma totale o di riforme parziali?
Non credo che con rivoluzioni o revisioni totali si arrivi da qualche parte. Bisogna pensare a riforme, riforme concrete. Sono cambiamenti magari piccoli, ma che affrontano problemi gravi e immediati, che mutano con il tempo.
Per esempio, oggi abbiamo un problema abitativo, una manifestazione chiara dell’impossibilità di fidarsi della garanzia di un diritto fondamentale.
Occorre fare riforme, e nel caso dell’abitazione è evidente. Lo Stato sociale dovrebbe garantire questo diritto, ma non lo fa, e ciò genera inevitabilmente sfiducia.
Il diritto esiste, anche se non è riconosciuto come fondamentale nella Costituzione, ma dovrebbe esserci una garanzia da parte dello Stato, di uno Stato che si definisce sociale, per assicurarne l’effettività. E questo non avviene.
Abbiamo i principi, ma non i fatti. Per recuperare la fiducia, bisogna passare dai principi ai fatti. Quando vedremo che certe aspettative si realizzano davvero, allora torneremo a fidarci.
Lei sostiene che i cambiamenti sociali nascono più dai mutamenti mentali che da quelli legislativi. In un periodo di grande polarizzazione, quale mentalità pensa che possa prevalere, e con quali conseguenze?
Più che ai quadri mentali, io attribuisco la sfiducia a una concezione troppo atomistica della libertà. Gli individui si comportano come nomadi, interessati solo a se stessi, che intendono la libertà come il fare ciò che ritengono più conveniente per il proprio interesse. Mancano legami sociali, manca coesione, e dunque il senso del dovere collettivo, della responsabilità condivisa nell’affrontare certi problemi.
Questa dimensione cooperativa, la democrazia liberale non è riuscita a svilupparla da sola.
Non siamo stati capaci di aggiungere qualcosa che favorisca la cooperazione, l’impegno per il bene comune, la non indifferenza.
Lo Stato e le istituzioni hanno molte colpe, ma anche gli individui: la società civile si impegna poco e mostra poca volontà di affrontare le grandi sfide del presente.
Nel libro lei afferma che non abbiamo ancora chiarito quale tipo di società vogliamo e come arrivarci.
Sì, ma non bisogna neanche delineare un modello di società ideale, come facevano le utopie.
Una società perfetta, come quella completamente statalizzata, è molto pericolosa e conduce al totalitarismo.
Bisogna invece affrontare concretamente i nuovi bisogni, correggere ciò che non funziona o non funziona affatto, senza cercare di disegnare una società perfetta, perché nessuno sa cosa sia davvero una società perfetta. Il cammino verso il miglioramento lo faremo correggendo, passo dopo passo, le disfunzioni della società.
Una di queste disfunzioni è il concetto di libertà. Si è pervertita la nozione di libertà fino a sfociare in una sorta di anarchia sociale?
Non direi anarchia, nel senso di dire “no allo Stato”. Piuttosto, deleghiamo allo Stato questioni che forse dovremmo risolvere noi stessi. Soprattutto, manca l’impegno per un bene comune che coinvolga tutti.
La concezione predominante della libertà oggi è quella che la filosofia definisce negativa, non positiva. È una libertà che non si chiede: “Perché voglio essere libero?”, “A che cosa mi impegna la libertà?”, “Quali doveri implica la libertà che possiedo?”, “Ho qualche dovere verso la società?”, “Ciò che sto per fare è la scelta migliore non solo per me, ma per la collettività?”. Queste domande non ce le poniamo più.
Ecco perché la libertà oggi vacilla e non aiuta a costruire un demos con un modo comune di essere che ci renda più democratici, più solidali, più fraterni, più rispettosi e più giusti.
Parlando di costruire questo demos, lei elogia la “cultura dell’accoglienza” di Merkel verso i rifugiati nel 2015. La mancanza di questa cultura nella nostra classe politica, in un contesto di politiche identitarie, è un esempio di fallimento collettivo?
Sì, perché va contro un principio fondamentale: il riconoscimento della dignità di ogni persona. Questo principio dovrebbe portarci all’accoglienza, all’ospitalità, qualcosa che, quando si parla di politiche migratorie, è chiaramente assente. Non esiste la volontà di accogliere l’altro che chiede aiuto e protezione.
Eppure, come molti riconoscono, l’arrivo di popolazioni migranti non ci danneggia né sul piano lavorativo, né sui servizi sociali, né su quello fiscale o del finanziamento dei servizi pubblici. Anzi, rappresenta un aiuto, ma non viene percepito così.
La prima reazione è il rifiuto dell’altro perché è diverso, perché disturba, perché non piace il colore della sua pelle, o per qualsiasi altra ragione.
Uno dei temi centrali del libro è l’educazione. Lei sottolinea il paradosso: abbiamo eliminato l’analfabetismo, ma non siamo migliorati moralmente. Perché?
Credo che non abbiamo risolto ciò che chiamiamo “educazione ai valori”. Innanzitutto perché l’espressione è troppo vaga: non abbiamo trovato la formula giusta.
Parlare di “educazione civica” è un po’ più concreto e significativo. Ma educhiamo davvero per formare cittadini? Persone capaci di correggersi da sole di fronte alla concezione consumistica della libertà, di impegnarsi nel mondo in cui vivono, di pensare agli altri e di imparare a pensare con la propria testa?
Questo è il principio che Kant considerava segno di una comunità illuminata: una comunità capace di superare la propria minorità e di pensare autonomamente.
Trasmettere il valore del pensiero autonomo, dell’impegno sociale, dell’autolimitazione, del saper rinunciare all’immediato soddisfacimento dei desideri: tutto questo, l’educazione lo trasmette davvero? Io credo di no.
Anche l’educazione morale è stata ridotta a una materia scolastica. Come si dice oggi, è diventata una “competenza” tra le altre.
Bisognerebbe chiarire cosa significhi “competenza morale”, perché nessuno lo spiega. Forse significa molto di più di quanto si pretende insegnare con qualche ora di etica. Aristotele lo aveva chiarissimo, e io ripeto sempre la sua lezione: “La morale non si insegna come una materia qualsiasi”.
Non si insegna come la matematica o la geometria. Si insegna con l’esempio, con l’imitazione, creando situazioni in cui la formazione morale sia vissuta. È lì che si impara a distinguere ciò che si deve e ciò che non si deve fare. Questo sforzo, che è pratico e non solo teorico, oggi non lo vedo.
Trasformare la formazione etica in una disciplina solo teorica non è la strada giusta: serve a capire concetti e ragionamenti morali, ma la pratica si impara in altro modo.
In questa linea, lei critica il fatto che, pur essendo l’educazione ormai laica, il processo non sia stato fatto bene, perché si è rinunciato a un’educazione etica capace di distinguere il bene dal male senza criteri religiosi.
Sì, perché la religione sapeva farlo, ma legandolo a una dottrina religiosa. Questo legame formava persone credenti che collegavano il proprio comportamento a una dottrina morale.
Ciò avveniva attraverso la religione, poiché il concetto stesso di religione implica il legare le persone, mantenerle in una comunità che sa cosa deve fare, perché possiede convinzioni da cui nasce un comportamento morale.
Con la secolarizzazione della società, ciò che la religione faceva non è stato sostituito da nulla che riesca a unire le persone in senso morale. Non abbiamo trovato il modo di creare una sensibilità morale, e questo è un problema.
Per dirlo in modo concreto: nel nostro caso siamo passati da un regime franchista, nazional-cattolico e dittatoriale, a un regime democratico. Abbiamo pensato che creando istituzioni democratiche saremmo diventati automaticamente democratici, che le persone avrebbero cambiato mentalità.
Ciò è avvenuto solo in parte, ma non in modo soddisfacente, nel senso di creare una comunità di persone consapevoli dei difetti e delle sfide della società, disposte a correggerli insieme.
Quindi, quasi cinquant’anni dopo la morte di Franco, non siamo riusciti a creare un demos veramente democratico?
È un demos liberale, ma con una concezione della libertà molto riduzionista e semplicistica, inculcata soprattutto dall’economia dei consumi e non da una motivazione etica.
Victoria Camps © Espacio Fundación Telefónica / Javier Arias





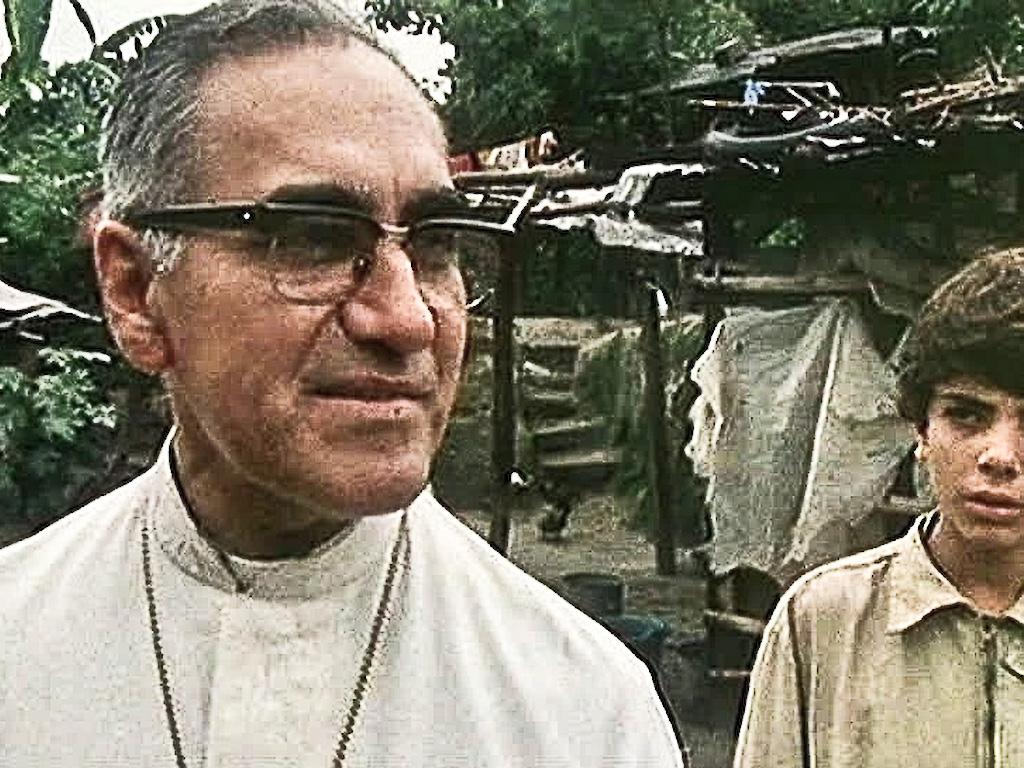
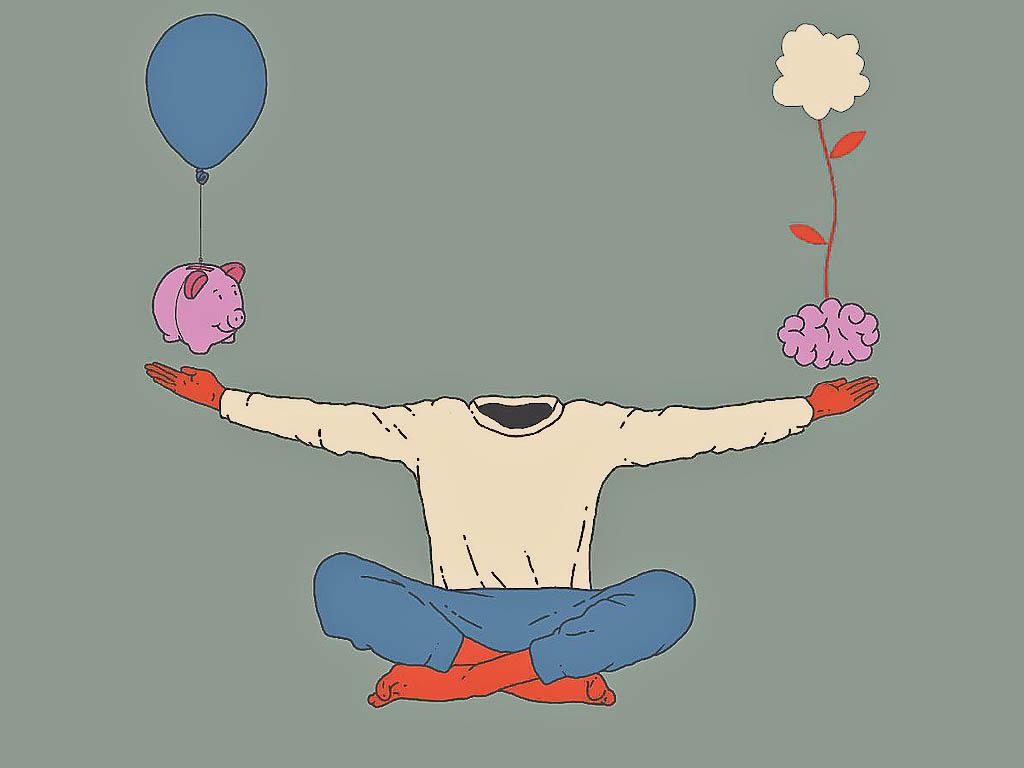
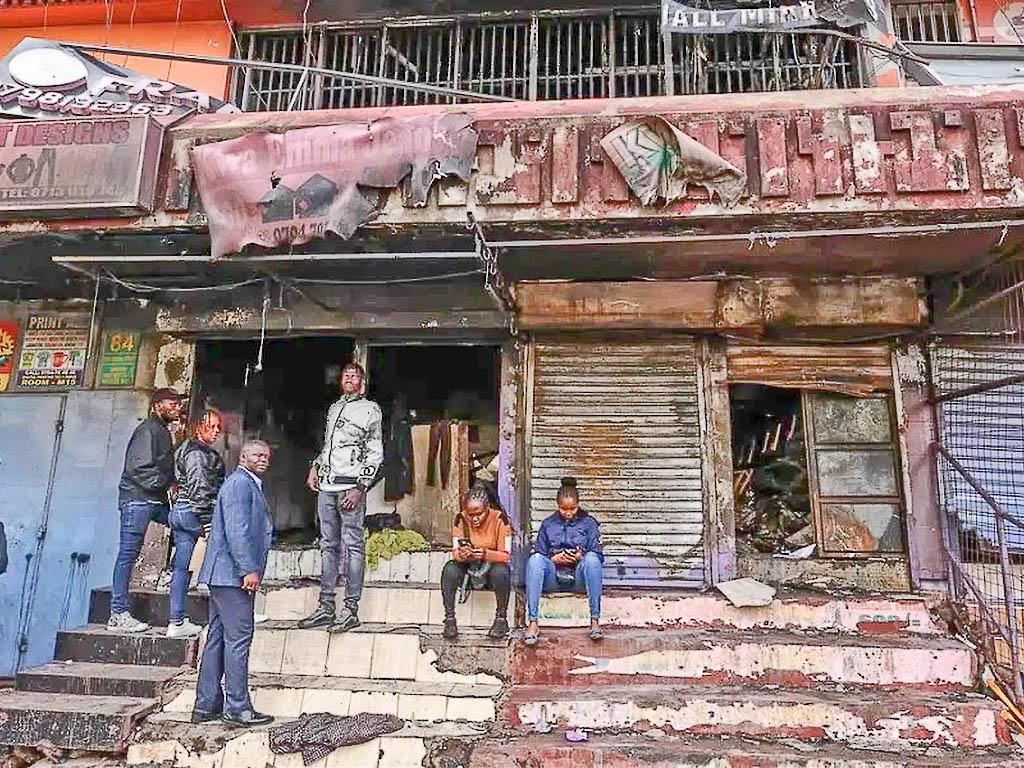

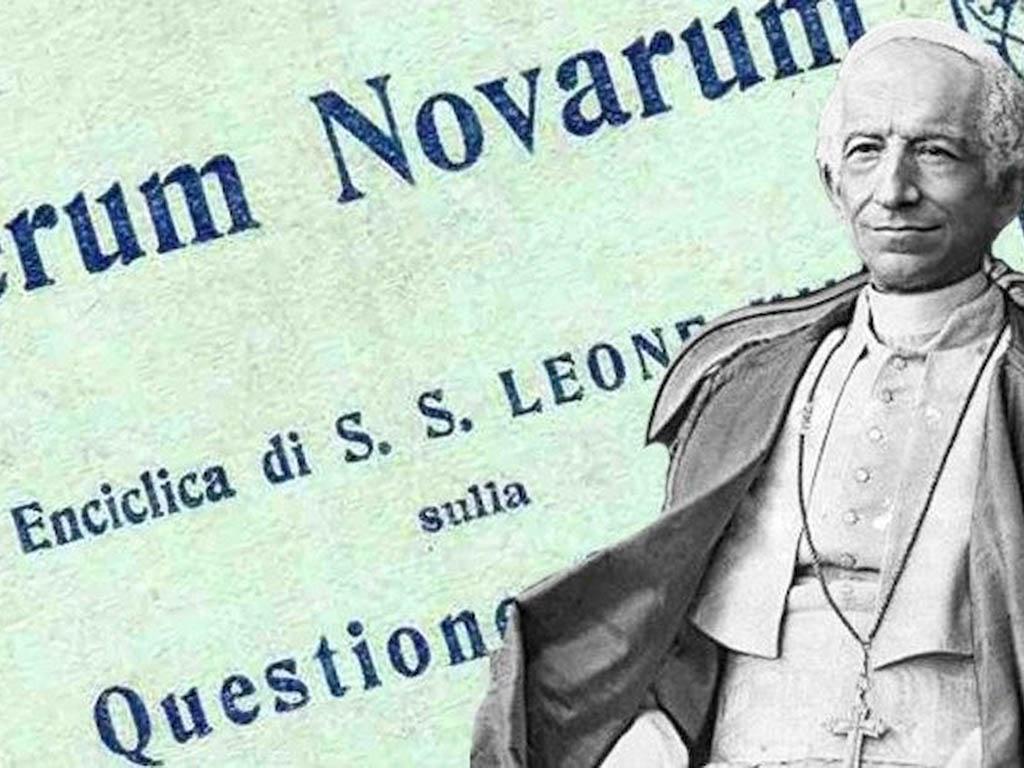



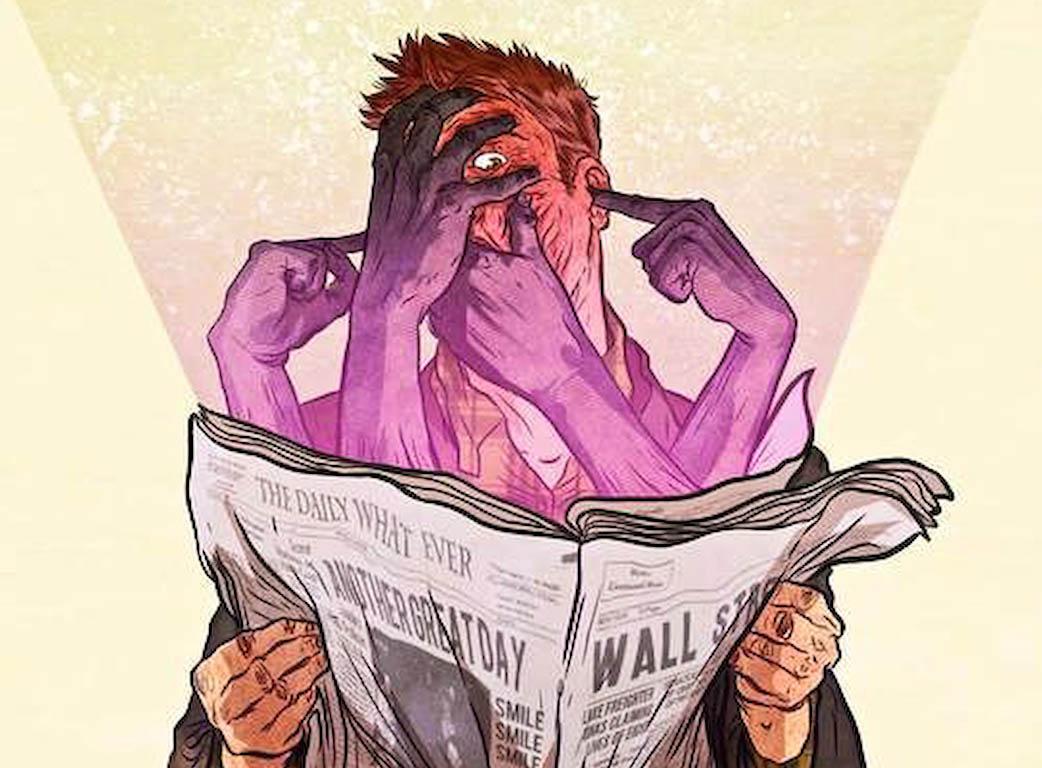







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento