Sogno un mondo senza rifugiati
ChimpReports 25.06.2025 Dr. Théogène Rudasingwa Tradotto da: Jpic-jp.orgHo imparato l’alfabeto e i numeri sotto un’acacia rinsecchita, nel campo di Rwekubo, nell’Uganda occidentale, con una latta arrugginita come ardesia e l’ombra mobile delle foglie come aula scolastica. Una buona riflessione in occasione della Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati, celebrata nella Chiesa Cattolica il 4 e 5 ottobre 2025.

Quelle mattine — terra rossa e sabbia sotto i piedi nudi, il morso della fame nello stomaco, il sussurro ostinato di mia madre che diceva «imparare è libertà» — non mi hanno mai abbandonato. Ho vissuto sulla terra del Ruanda solo per sei anni della mia vita, ma il Ruanda ha abitato in me in ogni istante. L’esilio ha plasmato l’intreccio stesso della mia identità, imponendo la domanda che tormenta ogni rifugiato: dov’è la casa quando la strada non finisce mai?
Da sempre, i filosofi si sono confrontati con questa domanda. Diogene si definiva kosmopolites, cittadino del mondo, non come vanto, ma come lamento per un’appartenenza perduta. Hannah Arendt avvertiva che il rifugiato del XX secolo era «l’avanguardia del suo popolo», segno profetico di Stati che avevano dimenticato come proteggere i propri cittadini. Anche la teologia è intrisa di esilio: Abramo ascolta la promessa di Dio solo dopo aver lasciato Ur; Mosè incontra il Roveto Ardente mentre pascola le pecore su un monte straniero; Maria, Giuseppe e il bambino Gesù fuggono dal terrore di Erode in Egitto; l’hijra del Profeta Maometto trasforma la fuga nel momento fondativo di una nuova comunità. Anche la scienza ci ricorda che l’homo sapiens è una specie migratoria. La genetica racconta un’antica irrequietezza che ha disperso i nostri antenati dalla Rift Valley fino a ogni riva, dimostrando che il movimento è naturale alla nostra specie quanto il linguaggio.
Eppure, muoversi per scelta è pellegrinaggio; muoversi per costrizione è tormento. Oggi, domina il tormento. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati riporta che, alla fine del 2024, 123,2 milioni di persone erano sfollate con la forza — di cui 36,8 milioni rifugiati e 73,5 milioni sfollati interni. Questo numero è sempre molto alto nella prima metà del 2025, raggiungendo circa 122 milioni, nonostante alcuni ritorni, quasi raddoppiando rispetto a dieci anni fa (unhcr.org, apnews.com). L’Africa subsahariana sopporta un peso enorme: il Centro di Monitoraggio degli Sfollamenti Interni segnala 38,8 milioni di africani sfollati all’interno dei propri confini, quasi la metà del totale mondiale (internal-displacement.org). La guerra civile in Sudan, da sola, ha sfollato oltre quattordici milioni di persone, mentre Congo, Mozambico, Somalia, Etiopia e Sahel sanguinano silenziosamente nelle statistiche.
Dietro ogni numero c’è un volto. Pensiamo ad Albert Einstein, che scrisse l’equazione che piegò l’universo mentre attraversava gli esili svizzero, tedesco e americano. Pensiamo a Sigmund Freud, Hannah Arendt, Joseph Brodsky; a Ngũgĩ wa Thiong’o che scrive Il diavolo sulla croce su carta igienica in una prigione di Nairobi; a Freddie Mercury che si reinventò da rifugiato di Zanzibar a icona del rock; a Madeleine Albright, che fuggì prima da Hitler e poi da Stalin, prima di consigliare i presidenti americani. L’esilio ferisce, ma può anche affinare la visione, distillare ciò che le società sedentarie non vedono più. Nei deserti, i profeti vedono roveti ardenti; nella desolazione, i rifugiati talvolta intravedono futuri che le società stabili hanno dimenticato come immaginare.
Questo paradosso — la tribolazione che genera rivelazione — alimenta la mia speranza. Non è il destino a condannare il XXI secolo a ondate sempre maggiori di sfollati; sono il fallimento politico, la negligenza ecologica e la lassità morale. Per fermare il diluvio, dobbiamo affrontare le cause, non solo i sintomi. Permettetemi di delineare un’agenda in sette punti — intessuti come un unico filo e non come un elenco — che mira a un mondo in cui la fuga sia una scelta e non una necessità.
Primo, le nazioni devono ricostruire la struttura fragile della pace preventiva. Il costo di una mediazione precoce dei conflitti è insignificante rispetto a quello del mantenimento dei campi profughi. Secondo, la sovranità deve essere ridefinita come responsabilità, non come controllo: i governi che commettono atrocità, affamano le popolazioni o privano i cittadini dei loro diritti devono affrontare sanzioni automatiche, giuridicamente vincolanti — economiche, diplomatiche e personali — applicate da un Consiglio di Sicurezza rivitalizzato, libero dal blocco dei veti. Terzo, è urgente la giustizia climatica. La scienza già dimostra che deserti in espansione, piogge fallite e mari in crescita sfollano ogni anno più famiglie delle pallottole. Un fondo globale per l’adattamento climatico — finanziato da una tassa sui profitti straordinari dei combustibili fossili — dovrebbe destinare direttamente risorse alle comunità vulnerabili, permettendo loro di restare in loco prima di essere costrette a fuggire.
Quarto, le economie devono essere riformate per incentivare l’inclusione. Sistemi di commercio equo, cancellazione del debito legata a riforme di governance, e accordi regionali di libera circolazione — come l’AfCFTA africano (African Continental Free Trade Area - la Zona di Libero Scambio Continentale Africana) — devono essere finalizzati e applicati per trasformare le frontiere da barriere in ponti. Quinto, la cittadinanza stessa deve evolversi. Ogni bambino nato senza cittadinanza dovrebbe ricevere il jus soli nel luogo in cui prende il primo respiro; i percorsi verso la naturalizzazione devono essere semplici, rapidi e accessibili; e i passaporti devono tornare a essere simboli di dignità, non strumenti di esclusione. Sesto, la conoscenza deve circolare più velocemente delle persone costrette a muoversi: bisogna investire in banda larga, università a accesso libero e certificazioni digitali, affinché nessuna guerra possa rendere orfano il futuro di uno studente o distruggere i suoi titoli di studio. Settimo — e fondamentale — la società civile deve essere protetta come il sistema immunitario della democrazia. Dove i giornalisti possono informare liberamente, le chiese offrire rifugio, gli scienziati lanciare allarmi e gli artisti conservare la memoria, le società individuano i problemi in tempo; dove la società civile viene repressa, le crisi si aggravano nell’ombra fino a far scorrere i flussi di rifugiati attraverso i continenti.
Nessuna di queste proposte è economica o semplice. Ma neppure lo è la situazione attuale, se misurata in infanzie perdute, speranze annegate e miliardi spesi dai donatori a malincuore per evitare che i campi si trasformino in cimiteri. La mia stessa vita dimostra che salvare anche un solo bambino dalla mano gelida dell’esilio può portare quel bambino a servire, curare e insegnare a molti altri. Immaginate allora cosa potrebbe guadagnare l’umanità se l’esilio stesso diventasse obsoleto.
Così sogno — non per capriccio, ma come obbligo morale — un’alba in cui la parola “rifugiato” tornerà alle antiche Scritture e agli archivi impolverati, non più titolo di prima pagina o campo aggrappato ai margini del deserto. Sogno un Ruanda i cui figli e figlie viaggeranno solo per scelta, le cui colline custodiranno la memoria senza lutto; un’Africa che esporterà idee, musica e innovazione, e non corpi disperati su barche fatiscenti; un mondo in cui il vagare torni a essere pellegrinaggio e non fuga. Fino a quell’alba, porterò dentro di me il deserto come ferita e come sorgente, ricordo che dalle tende lacere possono nascere visioni capaci di ricostruire le nazioni. E lavorerò — come rifugiato, medico, insegnante e cittadino di un futuro incompiuto — per il giorno in cui nessun bambino memorizzerà la mappa dell’esilio prima di aver imparato l’inno della propria casa.
Vedi, BLOG: I Dream of a World without Refugees | ChimpReports
Contact: ngombwa@gmail.com






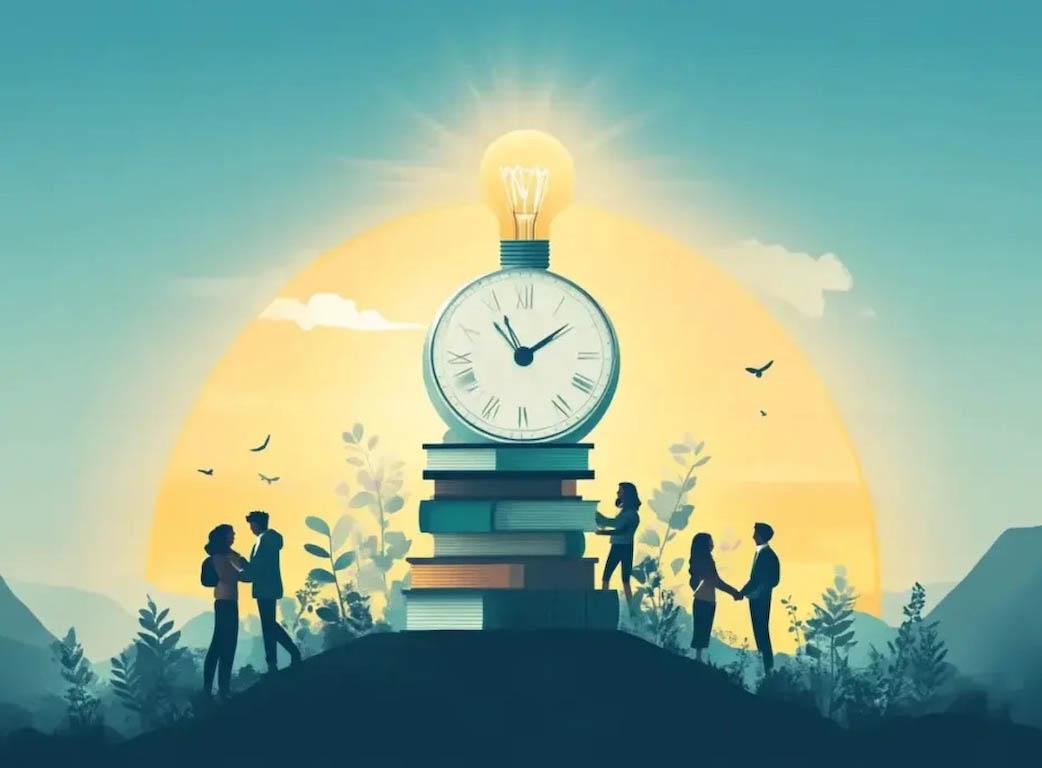






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento