Davanti alle sfide che dobbiamo affrontare
Butembo 20.09.2025 Jpic-jp.org Tradotto da: Jpic-jp.orgManifestazioni, flottiglie, manifesti, scioperi per reclamare i diritti dei palestinesi, degli agricoltori, dell’Ucraina e la lista diventerebbe lunga se volesse essere completa. Da tutte le parti si alzano voci contro le ingiustizie che si commettono nel mondo, le guerre, i disastri ambientali che si vedono, ma…

Pochi si fanno responsabili di due peccati d’omissione della storia recente: l’educazione al bene comune e alla fraternità, fondamentale per una società giusta e solidale; la responsabilità di non saper prevedere le conseguenze nel futuro delle azioni presenti.
Bene comune e fraternità
Come dice un proverbio africano: “Quando ognuno pensa solo alla sua brocca, il villaggio muore di sete”. Educare al bene comune e alla fraternità rappresenta un principio fondamentale per la costruzione di una società giusta e solidale: Alcide De Gasperi, statista italiano e uno dei padri fondatori dell’Europa comunitaria, fece di questo ideale la sua vita. La sua visione politica e la sua azione furono sempre orientate alla promozione della pace e della solidarietà tra le Nazioni. De Gasperi credeva fermamente che solo attraverso l’unione dei popoli europei, superando le divisioni e le rivalità storiche, sarebbe stato possibile garantire un futuro di stabilità, prosperità e giustizia per le generazioni future.
Lo statista, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu uno dei protagonisti del processo di ricostruzione dell’Italia e dell’Europa. Consapevole delle tragedie che avevano segnato il conflitto, lavorò instancabilmente per promuovere una visione di Europa basata sul dialogo e sulla collaborazione, senza se e senza ma. Il suo impegno fu determinante per la creazione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio nel 1951, uno dei primi passi verso l’integrazione europea. La CECA mirava a mettere sotto controllo comune le risorse strategiche dell’industria, garantendo che nessun paese europeo potesse più utilizzare tali risorse per scopi bellici, ma solo per la crescita e il benessere collettivo.
La base del suo approccio era la fraternità tra i popoli, nella consapevolezza che la solidarietà e la cooperazione erano la chiave per superare i conflitti e costruire un futuro di pace. Vedeva l’Europa come una “comunità di destino“, dove ogni nazione doveva contribuire al bene comune, mettendo da parte interessi particolari e privilegi nazionali per favorire il progresso collettivo. Questo concetto di unione solidale si riflette nei principi fondanti dell’Unione Europea, che, pur nelle difficoltà e nelle sfide, dovrebbe continuare a promuovere una cooperazione basata su valori condivisi di pace, democrazia e rispetto reciproco.
L’esempio di De Gasperi, anche e soprattutto oggi, è più che mai attuale: l’Europa affronta nuove sfide globali, come i dazi, la crisi migratoria, le disuguaglianze economiche e la crescente polarizzazione politica. Educare al bene comune e alla fraternità significa lavorare costantemente per una convivenza pacifica e prospera tra le diverse culture e nazioni, valorizzando le diversità e costruendo insieme un futuro migliore, senza alcuna esitazione e valorizzando il principio di fraternità a tutto campo.
Purtroppo sorge il dubbio che pochi siano i politici che hanno una visione del bene comune da statisti.
Prevedere le conseguenze delle azioni presenti
Come dice un altro proverbio africano: “Chi taglia l’albero dell’ombra, domani non avrà dove riposare né dove sedersi con il vicino”. Saper pensare il futuro è essenziale per prevedere le conseguenze del presente sulle generazioni future e sullo sviluppo delle vicende e delle relazioni fra i popoli.
Davanti alle accuse che paesi, organismi, opinioni pubbliche gli rivolgono per i massacri a Gaza, Netanyahu parla di “ipocrisia”, di “ipocrisia politica”.
L’ipocrisia è l’atteggiamento di chi dichiara valori, principi, sentimenti o intenzioni che in realtà non possiede o non segue. L’ipocrisia politica è questo comportamento nell’ambito della vita pubblica e del potere: si proclamano ideali di giustizia, pace o democrazia, ma in realtà si perseguono interessi personali o di partito; si promettono riforme, si difendono pubblicamente certi valori morali o religiosi, si dichiara di agire “per il bene del popolo”, mentre in realtà si cerca il potere o i privilegi di pochi. L’ipocrisia politica è la distanza tra il discorso pubblico e la realtà delle azioni.
Cosa intenda Netanyahu con questa accusa di “ipocrisia” è difficile saperlo: una consistente ipocrisia storica è, però, constatabile. Se l’accusa di genocidio è dubbia, evidente è la volontà di fare della Palestina l’unico Stato d’Israele, con il conseguente esodo globale dei palestinesi.
Ma già nell’epoca medievale correnti ebraiche pregavano e speravano per un ritorno a Sion; il sionismo come movimento politico e culturale nasce già alla fine dell’Ottocento, nel contesto di nazionalismi e di un antisemitismo crescente. La data simbolica della sua nascita è il 1897, quando Theodor Herzl organizzò a Basilea (Svizzera) il Primo Congresso Sionista.
E cosa si proponeva il sionismo? Da sempre fu: ricostruire l’identità ebraica fondando la patria per gli ebrei in Palestina. La Palestina era allora sotto l’Impero Ottomano. La Turchia, erede dell’Impero Ottomano, favorì questo progetto vendendo terre occupate dai palestinesi agli ebrei.
Più tardi, l’Inghilterra, che ottenne il mandato sulla Palestina, e i Paesi arabi, non si preoccuparono più di tanto del sionismo che l’antisemitismo dilagante solidificò e che la Shoah delineò come progetto politico ben preciso: lo Stato d’Israele.
Lo studio Una "questione ebraica" italiana al fronte orientale 1941-43 mostra che fu solo per il ruolo giocato dai tedeschi nella Shoah che ha portato, per esempio, “a trascurare quello degli alleati italiani”, e che in Ucraina, allora parte dell’Unione Sovietica, “vennero fisicamente eliminati circa 1,5 milioni di ebrei”.
Quando nel 1947 l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la Risoluzione 181, che prevedeva la partizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto regime internazionale, la maggior parte dei Paesi arabi si oppose rifiutando uno Stato ebraico.
E dopo la proclamazione di Israele (14 maggio 1948), gli eserciti di Egitto, Transgiordania (Giordania), Siria, Libano e Iraq, con il sostegno di contingenti e volontari di altri Paesi arabi, entrarono in guerra contro il nuovo Stato. Questo conflitto, noto come Prima guerra arabo-israeliana o guerra del 1948, ebbe come obiettivo dichiarato l’impedire la nascita e il consolidamento di Israele.
Il risultato fu invece la vittoria israeliana e l’ampliamento del territorio rispetto a quanto previsto dal piano ONU. Da allora in poi le guerre dei Paesi arabi, le minacce dell’Iran, di Hamas e Hezbollah hanno convogliato il conflitto “Israele – Palestina” su una strada diplomaticamente senza uscita, condannandolo alla sola soluzione per la violenza.
Come dice un proverbio africano: “Se hai smarrito la via, non la correggi correndo in avanti, ma tornando al giusto inizio”. Era forse quanto si proponevano alcuni Paesi arabi accettando i Patti di Abramo che Hamas e Iran vollero distruggere con il 7 ottobre.
Cosa rimase allora di spazio per il dialogo e la pace? Forse l’intuizione, ripresa con vigore da papa Francesco, che tutto è interrelazionato perché tutto ha una base e un’origine comune, pone l’interrogativo: non hanno forse il cambiamento climatico, la guerra di Israele a Gaza e tanti altri problemi della nostra società attuale radici comuni nel fatto che il "bene comune" dei popoli non è il fondamento perché le società attuali siano giuste e solidali?
Non sta l’incapacità di prevedere le conseguenze future di certe decisioni all’origine di tanti guai attuali? Chi dimentica il bene comune semina deserti e guerre e, senza sguardo al futuro, le azioni di oggi divengono i disastri di domani. La terra ferita e i popoli in guerra hanno la stessa radice: l’egoismo cieco. Se non si cerca il bene comune, si aizzano sia le fiamme della guerra che quelle del clima. Come dicono i proverbi africani:
“Chi accende il fuoco per bruciare il nemico, dimentica che il vento può bruciare anche la sua capanna”. “Chi non custodisce la terra e la pace, lascia ai figli polvere e lacrime”.
Vedi anche, Le nuove sfide globali che deve affrontare l’Europa











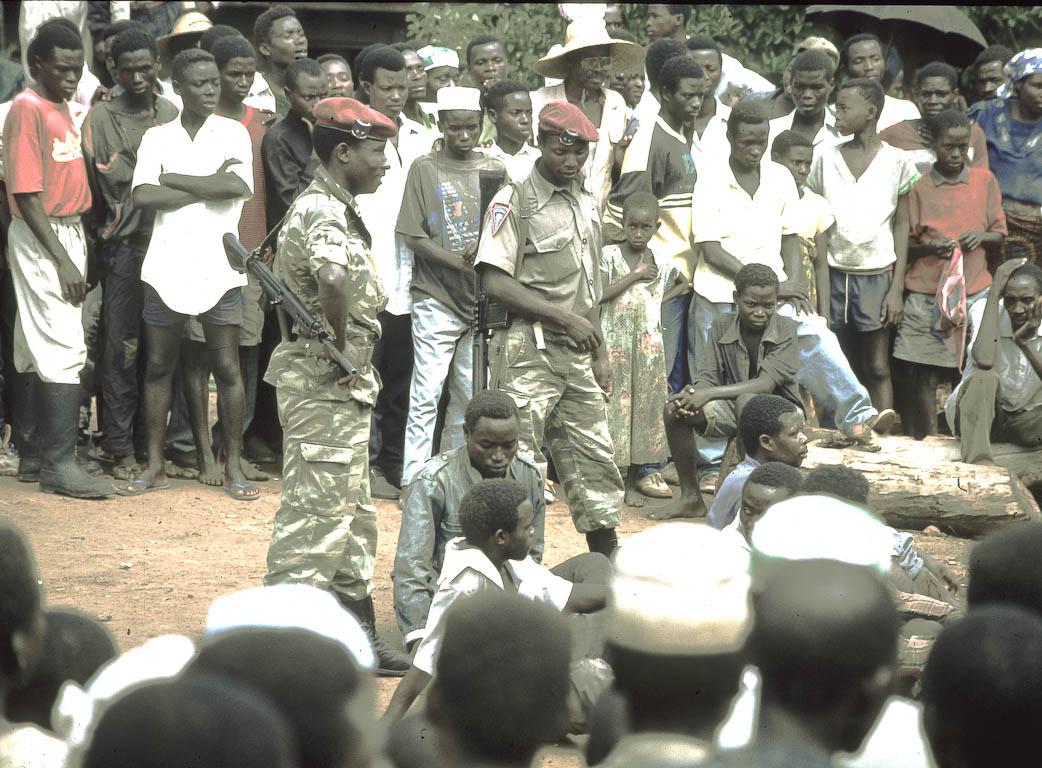









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento