Namibia, il genocidio dimenticato
Rivista Africa 02.10.2025 Annaflavia Merluzzi Tradotto da: Jpic-jp.orgIl 2 ottobre 1904 segnava l’inizio del genocidio coloniale tedesco contro le comunità Herero e Nama in Namibia. Oltre un secolo dopo, le ferite sono ancora aperte: nessuna riparazione concreta, una memoria ufficiale contestata e negoziati falliti. Le due comunità scendono in piazza per rivendicare verità, terra e giustizia.

Il 2 ottobre 1904 il generale tedesco Lothar von Trotha, comandante responsabile dell’amministrazione militare nei territori coloniali della Namibia, ordinava lo sterminio delle comunità Herero e Nama. Con quell’ordine cominciava il genocidio delle popolazioni indigene, che avrebbe visto la fine solo nel 1908, e si aprivano per la Germania le sperimentazioni sulle uccisioni di massa che avrebbero portato poi all’Olocausto.
Nell’arco di quei quattro anni si stima che circa l’80% degli Herero e il 50% dei Nama sia stato ucciso, tanto in forma diretta quanto attraverso lo sfinimento causato dai lavori forzati nei campi di concentramento, lo sfruttamento sessuale, le sperimentazioni mediche. E poi la fame e le malattie legate allo stato d’indigenza in cui versavano, il sequestro di bestiame e la costrizione nelle aree desertiche del Kalahari.
Oggi, le due comunità non vedono ancora riparazione per i torti subiti, rimangono costrette in una condizione di marginalità sociale e i loro appelli rimangono inascoltati. Oggi, le due comunità rivendicano il 2 ottobre come data nazionale.
Ha un sapore amaro, quindi, l’istituzione di un giorno della memoria che viene percepito come “di facciata”, perché scollato dagli eventi storici che hanno tracciato le linee del massacro. Quest’anno, infatti, la presidente della Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah ha celebrato per la prima volta il 28 maggio come giornata della memoria per il genocidio, un anno dopo la sua proclamazione. Si tratta della data in cui, nel 1907, furono chiusi i campi di concentramento. Nel suo discorso, Nandi-Ndaitwah aveva affermato che «quegli atti tremendi sono ormai parte della nostra storia collettiva di resistenza e resilienza nella nostra marcia verso la libertà», aggiungendo che «la nostra presenza in questa occasione segna un passo decisivo nell’elaborazione del passato, attraverso il ricordo collettivo e la condivisione del dolore delle comunità Herero e Nama».
Secondo Nandi Mazeingo, presidente della Ovaherero Genocide Foundation, «questo è un modo per mistificare la vera storia delle lotte anticoloniali coraggiosamente combattute dagli Herero e dai Nama, per cancellare il loro impegno nella difesa delle terre e del bestiame quando nessun altro osava farlo». L’ordine di sterminio del 2 ottobre, infatti, seguiva proprio la repressione dei moti di liberazione combattuti dalle due comunità, al fine di spezzarli e impedirne una nuova sollevazione. Per questa ragione, non riconoscendo il 28 maggio, i rappresentanti Herero e Nama hanno organizzato una celebrazione indipendente cominciata il 1 e conclusa il 2 ottobre, costruita sul ricordo storico dell’evento.
«Noi scegliamo il 2 ottobre per commemorare il massacro, nonostante il ricordo ci insegua ogni giorno perché continuiamo a vivere senza terra, senza bestiame, in esilio, povertà e marginalizzazione», spiega Mazeingo. La fondazione ha organizzato un raduno di massa che, partendo da Okahandja, marcerà fino alla capitale Windhoek attraversando i luoghi simbolici dello sterminio. Parate, esercitazioni militari e commiati passeranno di fronte la chiesa Luterana, considerata un «attore chiave nella realizzazione del genocidio», dove consegneranno una petizione al pastore. Lo stesso procedimento avverrà per l’ambasciata tedesca a Windhoek. La giornata si concluderà di fronte al Parlamento della Namibia, accusato di complicità nei ritardi sulle riparazioni e ritenuto incapace di farsi portavoce degli Ovaherero e dei Nama. «Passeremo anche di fronte al museo dell’indipendenza e le scuole, per educare il nostro paese e il mondo sulla nostra storia, ancora oggi esclusa dai curriculum scolastici e dalla narrazione pubblica. Lì il nostro capo supremo Mutjinde Ktjiua terrà un discorso per i media», spiega Mazeingo.
Le tensioni interne seguono anni di negoziati tra il governo della Namibia e quello tedesco, da cui gli Herero e i Nama hanno sempre lamentato l’esclusione. Nel 2021, dopo otto anni di mediazione diplomatica, Berlino propose un accordo da 1.1 miliardi di euro, da stanziare nell’arco di trent’anni sottoforma di finanziamenti infrastrutturali, formazione professionale, approvvigionamento idrico e progetti per riformare la distribuzione delle terre.
Nella bozza, però, non comparivano riferimenti alle riparazioni, nessun rappresentante delle due comunità era stato coinvolto per la stesura. Le proteste, portate avanti dai discendenti delle vittime, ottennero uno stallo nella firma, e culminarono in una causa, ancora in corso, intentata di fronte l’Alta corte del paese contro l’esecutivo. Le accuse nei confronti del governo vertevano sulla violazione di una risoluzione del parlamento namibiano del 2006: questa, infatti, prevedeva che al tavolo dei negoziati con Berlino sedessero direttamente i discendenti delle vittime, e che loro – e non lo Stato – dovessero beneficiare dei risarcimenti.
L’eredità post-coloniale del paese, un po’ come per il Sud Africa dopo l’apartheid e la prassi neo-coloniale in generale, vede ancora la minoranza bianca detenere la maggior parte della terra: questa costituisce infatti circa il 5% della popolazione, incluso l’1% che ancora parla tedesco, e possiede il 70% dei terreni agricoli. Berlino, dal punto di vista degli Herero e dei Nama, dovrebbe comprare la terra dai proprietari di lingua tedesca e consegnarla alle due comunità, per riparare davvero agli espropri subìti durante la dominazione.
L’inazione del governo su questa linea e il boicottaggio della data richiesta dagli Herero e dai Nama per la giornata della memoria, secondo Mazeingo, dimostrano «il collaborazionismo della Namibia con la Germania neo-coloniale». Le giornate hanno voluto riportare all’attenzione pubblica il fallimento dei negoziati, e spingere verso un’implementazione che sia in linea con la risoluzione parlamentare del 2006, perché «qualsiasi organizzazione sponsorizzata da entità al di fuori di noi non è nostra, non è per noi e perciò non vi prenderemo parte», conclude Mazeingo.










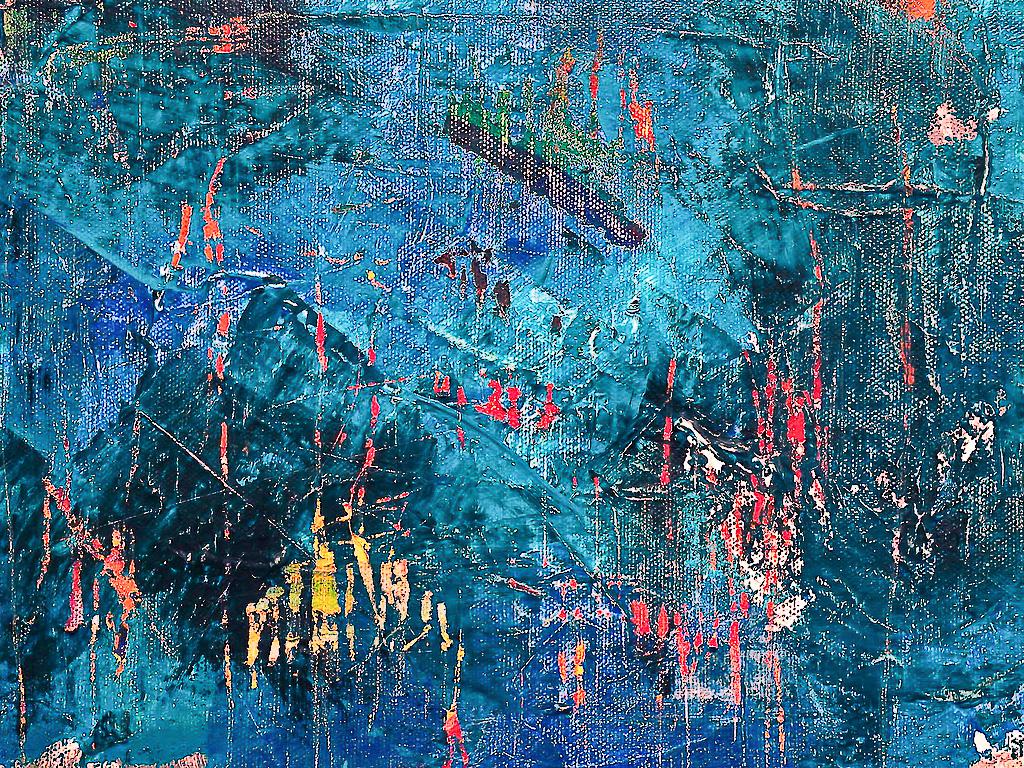


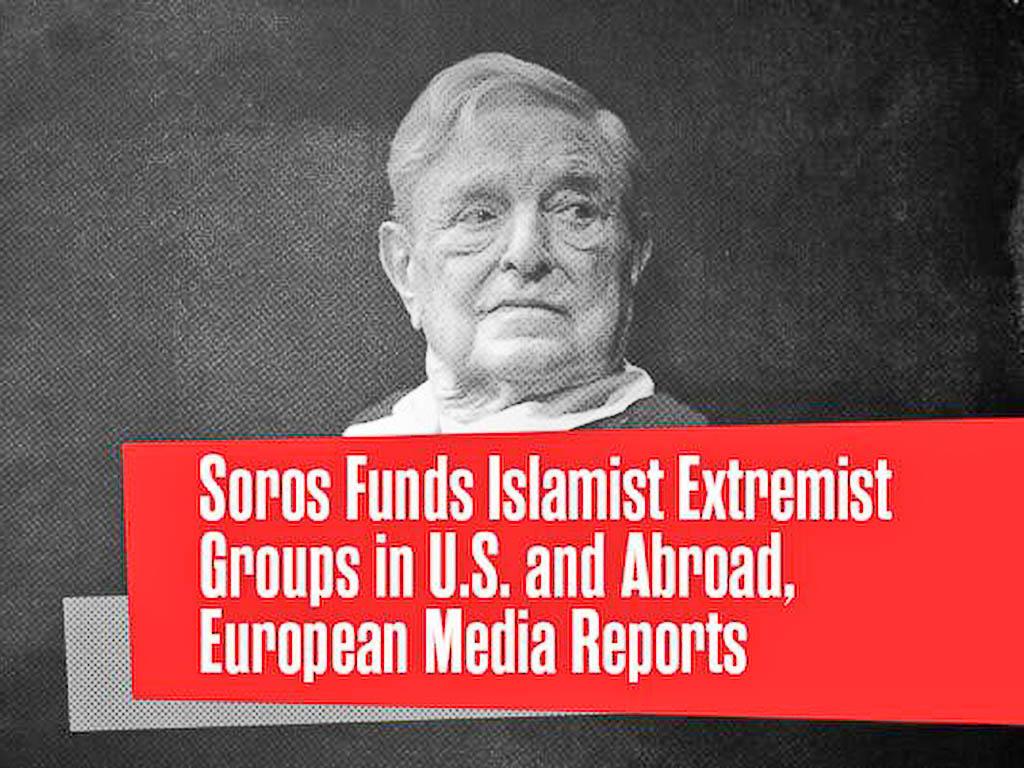







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Lascia un commento